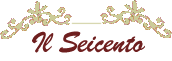
Nel
Seicento si impone in Francia il Barocco con lo stile Luigi XIII caratterizzato
dall'esuberanza dell'ornato e dalla ricerca del particolare decorativo
inconsueto e fantastico che stimola l'impiego di inateriali pregiati.
Di dimensioni imponenti, il mobilio barocco abbandona progressivamente
la linea retta per quella curva e spezzata e, rispetto al secolo precedente,
si distingue per una sensibile riduzione degli spessori del legno e
per una maggiore precisione nell'assemblaggio dei vari elementi. La
maggior parte degli incastri è ancora fermata da spine troncoconiche,
ma si va diffondendo l'uso della colla per rendere il tutto più saldo.
Si usano sempre i chiodi a sezione quadrata, la loro testa però diventa
più esile e piatta ed i chiodi vengono piantati alla traditora (diagonalmente),
con la punta che fuoriesce dal legno per essere successivamente ribattuta,
in modo da aumentare la tenuta. Tipico del mobilio barocco è il ricorso
alle forme curve ed ai ricchissimi ornamenti, con grande uso della scultura
e l'impiego di materiali preziosi (oro, argento, lacca e avorio) nella
decorazione. Assai diffusi sono anche i legni dorati, mentre pannelli
con pietre dure e applicazioni in bronzo dorato si usano per gli stipi,
che spesso diventano autentiche opere d'arte grazie all'inserimento
di marmi preziosi dipinti. Fa la comparsa il primo scrittoio con ripiano
liscio e cassetti disposti come fossero fregi oppure sovrapposti ai
due estremi del mobile e si diffonde la decorazione a tornio per le
gambe di tavoli e sedie. Si comincia a fare una netta distinzione tra
sedie e poltrone: gli schienali delle sedie sono di solito bassi, tranne
che in quelle di rappresentanza, ed al posto di sedili in legno da coprire
con cuscini prende piede l'imbottitura. Sviluppatosi in modi diversi
nelle altre nazioni d'Europa, il gusto barocco assume in Italia le forme
a volute e le superfici ondulate che si riscontrano nei mobili dell'area
romana, l'uso di formelle intagliate in Piemonte, il ricorso all'intaglio
esuberante in Veneto e Liguria. Nella decorazione del mobilio barocco
italiano si vanno diffondendo i motivi che richiamano l'acqua: tritoni,
conchiglie, cavallucci marini abbondano soprattutto nei mobili veneziani.
Nella seconda metà del Seicento la produzione francese di mobili abbandona
le influenze italiane e fiamminghe e assume una propria identità e omogeneità
stilistica: si va così affermando lo stile Luigi XIV. Il mobilio diventa
un vero e proprio monumento allo sfarzo, gli arredi sono riccamente
decorati e scolpiti, la tecnica delle intarsiature si fa sempre più
raffinata. Gli attrezzi impiegati nella lavorazione, sostanzialmente
invariati, diventano più precisi ed evoluti: compaiono strumenti per
le rifiniture come il pialletto a lama dritta (per livellare i piani),
il voltino (sega a lama stretta per sagomare le parti curve), la fustella
(per sagomare gli intarsi geometrici) e il seghetto da traforo (per
ritagliare gli intarsi più complessi). Maggior cura viene dedicata alla
levigatura e per la lucidatura comincia a diffondersi l'uso della gommalacca,
una resina diluita in alcool, che viene completata ancora con un'inceratura
a base di cera d'api. La tecnica della costruzione diventa più precisa,
si avvale di incastri realizzati con estrema cura, si fa abbondante
l'uso della colla tanto da rendere quasi superflue le spine che, quando
vengono impiegate, assumono una forma cilindrica e non più troncoconica.
Anche i chiodi hanno ora la testa rotonda e la gamba a sezione circolare.
La scelta dei legni si fa più ricca e variata, anche se il più diffuso
resta ancora il massello di noce, e cominciano a comparire tecniche
di lavorazione nuove come la placcatura (rivestimento di placche di
legni pregiati), l'incrostazione (tarsie con materiali diversi dal legno,
come avorio, madreperla e metallo) e la marqueterie (rivestimento con
legni sottili e colorati a formare disegni e figure). La forma di base
per i mobili di lusso, a parte i cassoni, resta ancora quella dello
stipo di Aversa, ma la struttura semplice viene sostituita da un disegno
che appare più sofisticato: cassetti e armadietti vengono rivestiti
frontalmente di pietre dure e la sontuosa intelaiatura è decorata con
ebano e bronzo dorato. Il cassone (commode) diventa il più diffuso contenitore
per la biancheria, anche se continuano ad essere costruiti alti guardaroba
(armoires). I mobili per sedersi diventano sempre più perfezionati:
i sedili sono ampi, con i braccioli pesantemente intagliati tanto da
riuscire scomodi, mentre si diffonde l'uso delle cinghie per sostenere
l'imbottitura della sedia, cinghie che vanno a sostituire il sistema
più rigido di assi inchiodate alle fasce. Viene ideata una poltrona
particolare, detta canapè, nella quale possono trovare posto due o tre
persone. Compare nell'arredo della camera da letto il comodino, un piccolo
cassettone dotato di tre o quattro cassetti, che viene utilizzato sia
come contenitore che come piano d'appoggio. Fa la sua apparizione anche
la console, un mobile che assume una funzione quasi esclusivamente ornamentale.
I tavoli alla moda hanno gambe, traverse e fasce molto lavorate. I materiali
più impiegati sono, oltre al legno, il marmo e il bronzo. Attraverso
combinazioni di materiali diversi come ebano, tartaruga, ottone, peltro
e madreperla si ottengono delle immagini di eccezionale valore decorativo.
Qualità principali di un mobile ben realizzato diventano la perfetta
aderenza dell'impiallacciatura, la qualità delle guarniture di bronzo
dorato o di ottone, il contrasto fra alti e bassi rilievi. Un motivo
decorativo molto diffuso è costituito dalle singeries, scene su ampie
superfici piatte che raffigurano scimmie nell'atto di imitare gesti
umani. Proprio in questo periodo compare in Francia la lacca, un nuovo
materiale importato dall'Estremo Oriente, che verrà ampiamente utilizzato
nel secolo successivo. In Italia i modelli proposti dallo stile Luigi
XIV vengono rivisti in chiave locale e viene riproposto il valore dell'intaglio
e delle dorature.